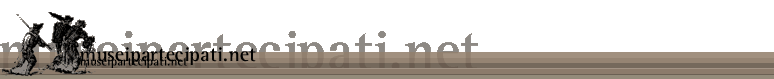Il Ciclo della vite e del Vino
L'arbustum gallicum
Vites maxime gaudent arboribus, quia naturaliter in sublime procedunt. Già l'agronomia classica aveva intuito, su una base empirica, che i vitigni crescevano e si sviluppavano meglio quando appoggiavano i propri tralci sulle ramificazioni degli alberi o li facevano correre, formando lunghi festoni, da un albero ad un altro. In entrambi i casi si realizzava una miglior esposizione all'aria e al sole dei grappoli d'uva e i risultati si sarebbero visti al momento della vendemmia.
L'arbustum gallicum, la vite a sostegno vivo, presumibilmente di origine etrusca, si diffuse già nell'antichità in Italia centrale e settentrionale. Il sostegno mutava secondo le morfologie del terreno, in collina si utilizzavano i tozzi aceri campestri, gli oppi, mentre in pianura per neutralizzare l'umidità del terreno si preferivano gli svettanti pioppi.
Le piantate e le alberate.
In Italia nell'età moderna quando, con la diffusione della mezzadria e dell'appoderamento a case sparse, la viticoltura riprese possesso di buona parte del territorio agrario, si impiantarono dei filari di vite ai bordi dei campi coltivati a cereali: le piantate in tutta la Pianura padana e le alberate nei rilievi appenninici dell'Italia centrale e settentrionale. Si trattava di due sistemi di vitigni che risultavano utilissimi perché "tenendo il prato sugli alberi" nuove risorse affluivano nell'economia di autosussistenza del mondo rurale. Dai filari, oltre alle uve per la vinificazione, si ricavava il fogliame da impiegare per il sostentamento del bestiame quando il foraggio scarseggiava, la foglia del gelso per la bachicoltura e la frutta per l'alimentazione famigliare o per le regalie ai proprietari terrieri quando i coltivatori erano dei mezzadri.
Il contratto mezzadrile, prevalente nelle zone delle piantate e delle alberate, prevedeva clausole che imponevano ai coloni l'obbligo di piantare ogni anno un certo numero di vitigni per assicurare un progressivo miglioramento del podere.
Nella seconda metà del Novecento la grande trasformazione dell'agricoltura italiana e il parallelo esodo dalle campagne avviò un lento processo di erosione dei secolari paesaggi a piantata e ad alberata. Mancava la manodopera necessaria alla manutenzione dei filari, diminuiva l'interesse dei contadini per le foglie da usare come foraggio e l'allevamento del baco da seta era sparito.
Le lavorazioni della vite
La vite richiedeva particolari attenzioni già al momento dell'avvio della coltivazione. Prima di mettere a terra le piantine si doveva procedere allo scasso del terreno: si scavavano delle fosse della profondità e della larghezza di circa un metro, che venivano poi riempite con la terra rimossa; in questo modo la vite attecchiva meglio.
Quando poi la vite era cresciuta si doveva concimarla, ogni tre o cinque anni, sotterrando il concime in fossetti attorno alle piante.
Ogni anno in primavera la vite doveva essere vangata e successivamente in estate zappata per mantenerne fresche le radici e per liberare il terreno dalle erbacce. Ugualmente ogni anno si dovevano verificare i sostegni vivi e le canne deteriorate (impalatura).
Da novembre alla primavera la vite veniva potata e legata: Si tagliavano i tralci superflui per consentire la fruttificazione dell'uva su un unico ramo. Si lasciava anche uno sperone con due gemme per consentire nell'anno successivo lo sviluppo di un nuovo tralcio sempre alla stessa altezza. Le viti venivano poi legate ai diversi sostegni con rami di vimini o rametti di ginestra.
Le malattie della vite e i trattamenti antipassitari
A metà del XIX secolo due micidiali malattie della vite, l'oidio prima e la peronospera poi, imposero l'adozione di trattamenti con sostanze a base di zolfo. Contro l'oidio, una muffa pulverulenta bianca che attaccava foglie e grappoli, si spargeva, con rudimentali soffietti, dello zolfo puro in polvere, mentre contro la peronospera, un fungo parassita, si irroravano i tralci con la poltiglia bordolese, una soluzione di solfato di rame e di idrato di calcio. I trattamenti antipassitari entrarono così stabilmente nella pratica viticola concentrandosi nei mesi tra maggio e luglio.
A queste malattie se ne aggiunse una terza ancor più rovinosa, la fillossera, un parassita animale dell'apparato radicale segnalato per la prima volta in Francia nel 1863. Contro la fillossera non servirono i trattamenti antipassitari, ma fu invece necessario spiantare e distruggere le piante infette e sostituirle con nuovi vitigni, fillossero resistenti provenienti dagli Stati Uniti (piede americano) su cui poi venivano innestati i vitigni locali. Questa costosa, ma efficace, soluzione fece sparire, nella prima metà del Novecento, la fillossera man mano che si manifestava.
La vendemmia
La vendemmia era preceduta dalla pulizia delle botti, dei tini e degli altri vasi vinari; il lavaggio era eseguito con sistemi diversi, ma era decisivo per la buona riuscita della vinificazione.
Quando l'uva era al punto giusto di maturazione cominciava la vendemmia che, come per la mietitura e la trebbiatura, era un momento di grande mobilitazione per il mondo contadino. Per vendemmiare i mezzadri ricorrevano allo scambio delle opere o ingaggiavano dei braccianti, se la manodopera delle famiglie non era sufficiente.
A metà mattinata, quando la rugiada era sparita, uomini e donne, ragazzi e ragazze si spargevano tra i filari e raccoglievano i grappoli usando non solo i tradizionali coltelli ricurvi (ronchette), ma anche i coltelli da cucina e le cesoie. Con l'uva raccolta si riempivano i canestri e le casse che venivano caricati sui carri e portati nelle cantine dei coloni, ma quando i coloni lavoravano per un grosso proprietario l'uva veniva caricata sui carri e portata nelle grandi cantine padronali, un avvenimento che creava grande scompiglio nelle piccole città del Montefeltro, come efficacemente narra per Urbino Alfredo Zampolini nel racconto, Avveniva in ottobre.
"L'arrivo dei birocci in città, ai primi di ottobre, era un avvenimento. Con le ruote grosse, a raggiera, cominciavano a entrare in città al mattino presto, duravano a passare per tutta la giornata. Erano quaranta, cinquanta birocci con le casse d'uva che i contadini portavano al padrone come parte sua. Le casse erano sistemate sui carri a più ripiani, legate con una corda. In cima era buttata una copertaccia per tenere lontane le vespe.
I birocci entravano (...) tirati da un paio di vacche legate al giogo. Le vacche le guidava il capoccia con la faccia nera e un cappello consumato in testa, dietro veniva il figlio giovane o un garzone che inciampava a ogni passo per la confusione che gli faceva la gente".
Pigiatura, torchiatura e fermentazione.
Dopo la raccolta dell'uva in certi poderi del Montefeltro si procedeva immediatamente alla pigiatura, come in Romagna, vicino ai filari dove era stato portato un tino. Di solito però l'uva veniva pigiata nelle cantine in un tino posto in alto sopra dei cavalletti o altri sostegni in legno: i ragazzi pestavano i grappoli e il mosto colava in un tino sottostante dove avveniva la fermentazione.
Il "miracoloso" mutarsi del mosto in vino, da millenni presente nell'esperienza umana, è stato dapprima circondato da un'atmosfera di mistero che ha finito per dare al vino e all'uva un importante ruolo anche nelle pratiche religiose.
Da pochi secoli è stato chiarito nella sua dinamica chimica e biologica: nel 1810 grazie alle osservazioni del chimico francese Gay-Lussac, venne scoperta la dinamica della fermentazione, consistente in una trasformazione degli zuccheri, contenuti nelle uve, in alcool etilico con uno sviluppo di anidride carbonica, un gas venefico che spesso mieteva vittime tra i cantinieri proprio durante la fermentazione.
Dal punto di vista biologico il processo venne chiarito, pochi decenni dopo, dallo scienziato francese Pasteur che identificò la causa della fermentazione nei lieviti, organismi monocellulari, che producendo gli enzimi, favorivano la trasformazione degli zuccheri in alcool. Questa interpretazione venne perfezionata dai fratelli Hans ed Edward Buchner che, avendo dimostrato come gli enzimi producessero la fermentazione, ricevettero nel 1907 il premio Nobel.
A fermentazione avvenuta un uomo servendosi di un attingitoio di rame (padlot) riempiva di mosto una bigoncina che poi veniva vuotata in una tramite un grosso imbuto di legno.
La pigiatura lasciava sul fondo del tino dei residui, le vinacce, costituite da graspi, bucce e semi; esse venivano raccolte e spremute in un torchio dove con successivi passaggi si otteneva dell'altro mosto che veniva poi riunito al mosto della pigiatura.XXX(il mosto della pigiatura veniva trattato a parte perché produceva un vino molto acido)
Alla pigiatura a forza d'uomo rimasta immutata sin all'antichità nel corso dell'Ottocento si venne affiancando la pigiatura e la pigiadiraspatura meccanica. Queste semplici macchine rendevano l'operazione più igienica, più regolare e più veloce e nel caso della pigiadiraspatrice separavano immediatamente i raspi dal mosto evitandone un eccessivo intorbidimento. Infine anche la successiva fase della fermentazione alcoolica ne traeva vantaggio perché, riducendo i tempi di spremitura, la fermentazione avveniva più omogeneamente.
Alla pigiatura seguiva, quando non era già stata ripartita l'uva, la divisione a metà del mosto tra il proprietario e il mezzadro.
L'acquaticcio.
Nelle cantine padronali le vinacce potevano essere utilizzate o come fertilizzante o mescolate nel mangime degli animali o distillate clandestinamente per produrre acquavite, nelle cantine dei mezzadri o dei piccoli coltivatori, una parte delle vinacce non venivano spremute al torchio, ma venivano lasciate nel tino, dove aggiungendo un po' d'acqua si otteneva un mezzo vino, acquaticcio, di bassa gradazione, destinato anch'esso al consumo domestico, mentre il vino di qualità migliore veniva venduto.
Si ha l'impressione che la famiglia mezzadrile, così come per il grano, si vedesse passare davanti la maggior parte e la miglior parte della vendemmia e si dovesse accontentare degli scarti della vinificazione. Questa canzone raccolta a Lamoli nel 1976 esprime efficacemente come la povertà abbia impedito al mondo rurale, mezzadri e piccoli contadini, di poter godere dei frutti migliori della terra e del proprio lavoro.
"Poi viene il tempo della vendemmia/ allora sì che si bestemmia/ si coglie l'uva, si pigia, si mette nella botte/ e poi si vende e buonanotte/ si prende tutta quella vinaccia/ si fa la botte d'acquetaccia/ e ci si beve tutto l'inverno/ sicchè soffrire le pene dello inferno".
Travasi e governa.
Nelle botti il vino diventava meno torbido e quindi veniva travasato per liberarlo dalle fecce che si erano sedimentate sul loro fondo. I travasi cominciavano a novembre e duravano sino al periodo natalizio, ma dovevano essere eseguiti durante la fase calante della luna, con clima asciutto e in assenza di venti caldi.
Il travaso consisteva sostanzialmente nel togliere il vino dalle botti riportandolo nei tini, mentre contemporaneamente si provvedeva a lavare le botti e a farle asciugare. Una volta che le botti erano risistemate in cantina vi si riponeva il vino.
Per ridare forza al vino si procedeva alla governa: si pigiava dell'uva passa e il liquido ottenuto si aggiungeva al vino che si stava travasando per elevarne la gradazione.